Dentro
- Reader for Blind

- 9 nov 2017
- Tempo di lettura: 1 min


Sandro Bonvissuto - Dentro (Einaudi)


Le guardavo. Era come se mi avessero tolto qualcosa di mio per sempre, come se quelle impronte me le stessero rubando. Per un attimo provai forte il desiderio di riprendermele. Ma mi guardavano tutti. Avrei dovuto quindi lasciarle lì, come una cosa in più che si aggiungeva a tutte quelle che avevo già perso o dimenticato in qualche posto. Da quel momento in poi avrebbero continuato a vivere ma senza di me. E io senza di loro.


Così, se vedi l'inizio di una strada, devi dirti che alla fine di questa c'è un posto. Tanto che ogni strada ha dentro di sè qualcosa del posto dove va a finire, e ha qualcosa del posto dal quale comincia. Ecco perchè la strada appare diversa se la percorri in un senso o nell'altro.


Mi abituai all'oscurità, e riuscii a vedere meglio. Erano in due. Se ne stavano stesi sulle brande alla mia destra. Uno sopra e uno sotto. Sulla parete in fondo c'era una finestra con i ferri, murata quasi interamente


Compresi allora come la loro prerogativa principale fosse seguire le persone con lo sguardo. In silenzio. Dovevano essere stati addestrati per questo. Poi mi fecero passare da una porta che dava su un corridoio lungo e vuoto, un corridoio che portava al centro dell'edificio.


Cinquantaquattro. Cinquantaquattro passi inutili, perché lì avrei scoperto che non si cammina mai senza motivo; normalmente si cammina per andare da qualche parte, o perché ci si aspetta che, camminando, la vita, o chi per lei, ci offra qualcosa, qualche possibilità.


L'unica misura valida del tempo dovrebbero essere i giorni, appunto. Tutti gli altri parametri dovrebbero essere considerati quello che sono: convenzioni sociali. Invenzioni. Gli esiti deliranti del perenne tentativo dell'uomo di dominare in qualche modo la sua più grande ossessione: il tempo. I giorni invece esistono davvero.


La morte non ti raggiungeva dall'esterno, ma da dentro. Era lì con noi. Sempre. In posti come quello il numero dei suicidi era molto più alto che all'esterno. Venti volte di più, aveva detto il prete.


Compresi allora la seguente cosa: il muro è il più spaventoso strumento di violenza esistente. Non si è mai evoluto, perché è nato già perfetto. E ti accorgi di tutta la sua potenza soltanto quando vedi un muro in funzione. Perché non tutti i muri funzionano; quelli che incontriamo nella vita di tutti i giorni, ad esempio, non sono veri muri. Sono interrotti, oppure hanno delle porte, insomma si possono in qualche modo aggirare o attraversare. E' come se fossero ordigni disinnescati.


E io stavo sempre con i romani, con "Mamma Roma". Si raccontavano poi grandi cose dei russi: mi dissero di uno grosso come un orso che una volta aveva smontato una pistola e l'aveva ingoiata. Nella categoria degli slavi erano compresi anche i rumeni, ma come enclave; le molteplici differenze etniche e linguistiche ne facevano un insieme a sé.


Di questa storia dello spazio parlavamo spesso in cella; eravamo tutti d'accordo che ci facesse male quell'inevitabile vicinanza. Una vicinanza che induceva i sensi a ridurre le informazioni trasmesse al cervello e costringeva a vivere in una stasi emotiva. Le sensazioni diventavano lì dentro cose stanche, minori, lontane, avvolte da una nebbia perenne. E tutto ti predisponeva al regresso inesorabile: il ritorno allo stadio fetale, percepivi che il mondo come se ti trovassi dentro l'acqua.


Steso di nuovo sul mio letto pensavo come fosse curioso che nel luogo dell'illegalità e degli illegali il rispetto delle regole di convivenza potesse assumere un valore così grande. Quando le persone non rispettano le leggi, pensavo, vengono rinchiuse. Eppure ci sono state anche leggi che non hanno rispettato le persone. Ma non le ha rinchiuse nessuno.


E' strano come in carcere cada così spesso qualcuno dalle scale, per quanto sembrino scale normali, come quelle che ci sono nei condomini, nei ministeri o negli uffici. Non saranno certo più difficili da fare delle altre. Non dovrebbero nascondere insidie. Anche i detenuti sembravano persone normali, gente che sapeva camminare, e quindi anche salire e scendere le scale. Senza cadere ogni volta. O magari solo una volta ogni tanto.


E così: quando arriva la mattina dell'interrogatorio - tu non dormi da tre o quattro giorni, e stai in piedi per scommessa -, tutti si prodigano per darti consigli, per sostenerti. Qualcuno che ce l'ha ti presta addirittura una camicia o una giacca. Poi vieni portato nell'auletta del carcere dove si svolgono le udienze; ti fanno sedere e tu non sai nemmeno bene come sei arrivato lì. Ti guardi intorno.


Quando ero piccolo in parrocchia i preti ti davano il pallone per giocare solo se prima avevi fatto la preghierina. Anche le suore, alle quali probabilmente l'avevano detto i preti di fare così. Insomma, giocavi soltanto se prima eri stato bravo. Però c'era chi giocava sempre, chi non giocava mai e chi giocava una volta ogni tanto. Io giocavo fra sempre e ogni tanto.


La notte guardavo i panni stesi; stavano fra un letto e l'altro, per aria. Sembravano pensieri. O sogni pesanti.


Mentre camminavo sul ballatoio mi ricordai di quando ero bambino e andavo alle giostre. Mi ricordai della gente che c'era intorno. Di quelle facce che vedevo di nuovo a ogni giro. Sempre là. Fermi. Tristi. E a ogni giro io mi chiedevo come mai non salissero anche loro.
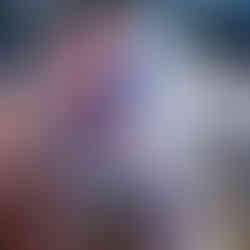

La prima volta che sono uscito dopo quattro anni non riuscivo più a caminare per la strada la notte. Ero terrorizzato dalle luci delle automobili, mi sembrava che mi venissero addosso, che ce l'avessero con me. Mi sentivo sicuro solo qui dentro. Così poi ho finito per tornare.


Nel giardino davanti casa mia c'è un albero di arance amare. Mi ero sempre chiesto a cosa servissero, perché non sono buone da mangiare. Qualcuno ci fa la marmellata, ma quella di ciliegie o di albicocche è sicuramente più buona.


Così ogni libro di storia è come un camposanto. Ora che ci pensavo avevano anche lo stesso odore. Vicino alla rilegatura. Lo potevi sentire bene se ci infilavi il naso dentro.


Doveva aver perso la mano in un'altra guerra ancora, come quella silenziosa e strisciante che si combatte ogni giorno nei cantieri edili delle grandi opere pubbliche o private, e nelle fabbriche, nelle officine di ogni paese industriale. Una guerra senza bombe nè proiettili, capace di fare lo stesso tantissime vittime. Non tutte insieme però, una alla volta.

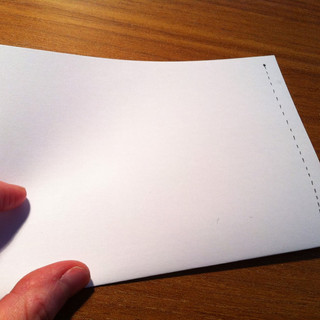
Non sappiamo niente di quello che ci deve succedere nella vita, poi un giorno qualcuno ci dice che certe cose che ci riguardano moltissimo stanno scritte su un foglio. Perché? Chi è stato? E inoltre, chiunque sia stato, come ha fatto a decidere? Ma soprattutto: perché poi ce lo dicono?


C'è un quadro di Renoir osservando il quale si può capire bene la sensazione che provai quel giorno. Nel dipinto sono rappresentate delle persone allegre che stanno in un posto a fare qualcosa. Dopo un po' che le guardi, ti rendi conto che l'immagine è effettivamente bella e serena, ma capisci anche che purtroppo tu non sei lì con loro. Sei in un altro posto. Li guardi da spettatore. E perciò, dal momento che non sei nel dipinto, non c'è nessuna ragione che tu sia spensierato e allegro.


A guardarlo, mentre si agitava affacciato dalla cattedra con la metà del busto, sembrava una marionetta uscita da un teatrino di legno molto popolare dalle nostre parti, che stava in un parco bellissimo e piccolo.


Era esattamente a questo che mirava l'istruzione obbligatoria: far emergere le capacità individuali all'interno di una collettività fingendo di unire, per dividere.


Ci piaceva così il nostro banco, che per ogni studente è un po' una casa. Per noi era una placenta gemellare. Un giorno non lo trovammo più. Non era da nessuna parte. Dovevano averlo portato via. Anzi deportato.


nsieme percorremmo quella strada, breve si, ma lunga abbastanza da diventare nel mio immaginario, per sempre, la strada per tornare a casa.


Ricordo solo che intorno a noi era pieno di gigli bianchi. Non davano l'idea di essere fiori ma riverberi del sole, avanzi di luce.


Noi sapevamo, più o meno consapevolmente, di essere diversi dagli adulti, e questa diversità era ciò che ci permetteva di vivere quell'incanto che aumentava sempre di più, per poi finire di colpo, con uno schianto secco.


La mamma è meglio vederla da vicino. Il padre lo capisci da una certa distanza. Non troppo, quanto basta. Dev'essere una questione d'inquadrature, come nei film.


I boschi hanno una loro naturale intimità. Sono come le chiese. Le pinte invece sono sontuose come le cattedrali. Lì è più facile parlare di cose di cui non parleresti altrove. Anzi forse sono queste stesse cose che ti parlano di più in quei posti, ariosi e illuminati. Quando in pineta arrivava qualcuno che non fosse del gruppo dei piccoli, lo vedevi mezz'ora prima.


- E' una dinamica unica attraverso cui ti definisci e ti conosci. E' la tua identità.
- Che identità?
- Ciò che ti rende uguale a te stesso e diverso dagli altri.
- E poi?
- E poi mi hai rotto i coglioni, prendi 'sta cazzo de bicicletta e pedala, - disse infine.
- Va bene, papà.


Poi lui se ne andò via improvvisamente e in silenzio, come quei calciatori che non esultano dopo il gol. Forse per celare un'inopportuna fragilità. Io invece rimasi, perché dovevo.










Commenti